Home » Articoli » Interview » Enrico Pieranunzi: Il Respiro Profondo di un racconto in musica
Enrico Pieranunzi: Il Respiro Profondo di un racconto in musica
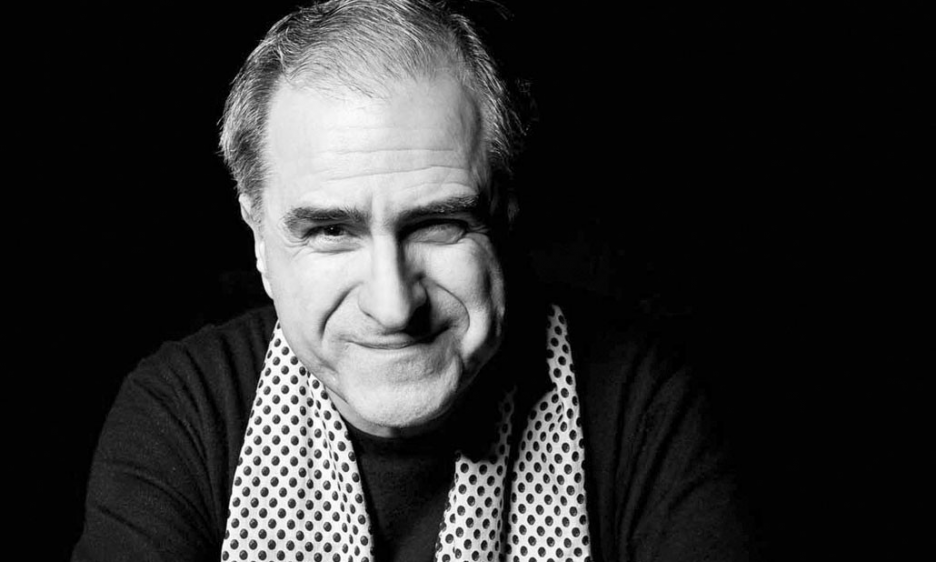
Quando inventi un pezzo che sai esser vero, lo puoi sentir respirare e vivere tra le tue dita
Partendo dai giovanili studi classici passando per il vulcanico fraseggio pianistico mutuato dai Maestri del Be-bop, fino all'incontro con l'essenzialità e meditativa purezza dell'amico e mentore Chet Baker, consacrata nel disco Soft Journey, e la conseguente riscoperta di Bill Evans, il pianista romano ha dato vita negli anni a un'intesa comunione con l'espressione musicale. Un modo per dare forma, a volte inusuale, ai propri stati d'animo e riflessioni nel momento stesso della creazione di un'idea musicale nel rituale infinito dell'improvvisazione.
Insieme a un'attenta, ma allo stesso tempo originale interpretazione delle partiture di Domenico Scarlatti e Claude Debussy, sin dai suoi primi lavori Enrico Pieranunzi si è imposto nel panorama del jazz internazionale come compositore raffinato di largo respiro. Negli anni, la scrittura musicale è diventata per lui un'esigenza imprescindibile che, nonostante il tempo, non rimane relegata a vecchi cliché e strutture stereotipate ma si apre a nuovi orizzonti di ricerca espressiva, evidente nei suoi ultimi dischi in trio New Visions e Common View. Un intenso slancio in avanti nella materia difficile del jazz che solo i grandi possono donare al proprio pubblico attraverso un linguaggio distinguibile, in tutta la sua profonda essenza.
All About Jazz: Ci sono incontri nella musica, come nella vita, che segnano i nostri percorsi portandoli in direzioni spesso inaspettate. Quello con il grande batterista Paul Motian è stato per te uno di questi.
Enrico Pieranunzi: Sì, è vero. Il nostro primo incontro fu al Festival di Roccella Ionica nel 1992 e si realizzò quasi per caso. Avevo incontrato mesi prima Paolo Damiani, direttore artistico di quel festival, che m'aveva chiesto: "Cosa ti piacerebbe fare a Roccella quest'anno?." Colto di sorpresa improvvisai e buttai lì quasi per scherzo "Suonare in duo con Paul Motian..." Damiani mi prese alla lettera e così il duo fu messo in programma nell'edizione di quell'anno. La batteria è uno dei miei strumenti preferiti e amavo—e amo—follemente il Motian dello storico trio con Bill Evans, ma anche quello più sperimentale e innovativo dei dischi in quartetto con Keith Jarrett, Charlie Haden e Dewey Redman, per non parlare di quello successivo, originalissimo, del trio con Bill Frisell e Joe Lovano. Probabilmente l'assenza del contrabbasso in quest'ultimo gruppo mi fece venire l'idea di un incontro a due, appunto senza contrabbasso. Idea che si rivelò più che giusta, perché l'incontro fu splendido. In fase di soundcheck chiesi a Motian se fosse interessato a provare. La risposta fu: "Assolutamente no." Ed ebbe ragione. Il concerto serale fu infatti una lunga, fluida, fantasiosa improvvisazione a due che si dipanò in piena libertà senza un attimo di respiro. La musica che ne venne fuori fu poi documentata in un CD il cui titolo, Flux and Change, rappresentava perfettamente quanto era accaduto sul palco. Fu pubblicato qualche tempo dopo dalla Soul Note ed ora è reperibile su etichetta Camjazz.
AAJ: Quell'incontro fu cruciale per la serie di concerti che hai tenuto al Village Vanguard a New York.
EP: Sì, fu l'inizio di una lunga e importante storia musicale il cui epilogo imprevedibile e glorioso ebbe luogo diciotto anni dopo, nel 2010, quando con Paul Motian e Marc Johnson suonammo una settimana al Village Vanguard e registrammo un CD live nel mitico club a forma di diamante. Mai prima d'allora—e neanche dopo—un musicista italiano vi aveva né suonato né registrato come leader. Era un sogno inaspettato che diveniva realtà. Ma, a parte questo, quella settimana fu un'avventura di estrema intensità da tutti i punti di vista, con alcuni risvolti simpatici.
AAJ: Fu Motian l'artefice del tuo primo concerto al Village Vanguard?
EP: Sì e no... Alla fine del 2009 ricevo una mail di Motian che mi dice: "Ti va di fare l'anno prossimo, a luglio, una settimana con me al Vanguard?" Mi stropiccio gli occhi un po' di volte, verifico di essere sveglio e naturalmente gli rispondo ok. Quando poi a luglio del 2010 arrivo lì, parlando prima di uno dei concerti nel "camerino," che è l'ex cucina del club, con lui e Lorraine Gordon, straordinaria musa del Vanguard purtroppo scomparsa nel giugno del 2018, vengo a scoprire che la vera ispiratrice di quella mail era stata lei. Aveva ascoltato da una radio di New York un mio pezzo dal CD Plays Scarlatti ne era rimasta colpita e aveva chiesto a Motian di cercarmi. Il problema è che per parecchio tempo la ricerca non era approdata a nulla perché avendo sentito l'annuncio del mio nome di sfuggita, Lorraine aveva riportato a Motian invece che Pieranunzi "Petrosino" e Motian ci mise un po' a collegare quel nome col mio. Quando riuscì finalmente e ,"creativamente" aggiungerei, a farlo mi scrisse.
AAJ: Quali ricordi invece hai della tua collaborazione con Paul Motian nel periodo precedente fra il 1992 e il 2010?
EP: Tour, registrazioni, soprattutto tanta meravigliosa musica insieme. Motian era molto più che un batterista e molto più che un batterista jazz. Era un compositore alla batteria, un musicista con una sua potente, originale visione della costruzione e della gestione degli spazi e dei colori musicali. La sua estetica sconfinava nella musica contemporanea del più alto livello ed era talmente personale che, un po' com'è accaduto a Monk nel pianoforte, Motian non ha avuto praticamente seguaci. Non era imitabile. Anche come compositore era molto particolare. Scriveva pezzi obliqui, suggestivi, misteriosi e molto suoi, talvolta con una venatura orientaleggiante legata probabilmente all'origine armena della sua famiglia. Insomma, era veramente un musicista enorme e per me è stato un grande privilegio non solo suonarci, ma che lui abbia amato suonare i miei pezzi. Tra questi prediligeva in particolare quelli più lenti, lirici, fatti di poche note, il che potrebbe sorprendere parlando di un batterista, ma appunto, lui era speciale. Tra i tanti CD insieme—credo siano otto—a parte il Live at the Village Vanguard del 2010 sono molto affezionato agli altri tre registrati per la Camjazz: Doorways, in duo, del 2002, per il quale scrissi appositamente tutti i brani pensando proprio al suo inimitabile linguaggio batteristico; Special Encounter, in trio con lui e Charlie Haden e, naturalmente Fellinijazz, in quintetto, con Motian, Charlie Haden, Kenny Wheeler e Chris Potter.
AAJ: Chris Potter fu una sua scoperta, giusto? Come del resto lo stesso Bill Frisell.
EP: Motian era un grande talent scout. Anche il chitarrista Kurt Rosenwinkel è stato scoperto e valorizzato da lui. Aveva l'occhio clinico per i nuovi talenti. Credo facesse parte di quella visione ampia di cui parlavo sopra. Cercava sempre di rinnovare il suono dei suoi gruppi, di andare avanti, di vedere lontano.
AAJ: Come influì su di te il fatto che fosse stato il batterista del primo storico trio di Bill Evans?
EP: Quando cominciammo a suonare insieme ero troppo preso dalla musica che facevamo per rendermene conto, ero come in una dimensione onirica. Poi piano piano cominciai a realizzare che oltre alla straordinaria opportunità musicale, mi trovavo a tu per tu con una fonte di primissima mano per informazioni "riservate," retroscena ecc. che riguardassero Evans. E poiché per una curiosa coincidenza, o forse una non-coincidenza chissà, poco dopo aver cominciato a suonare con lui mi ero immerso in un'altra avventura, quella di scrivere un libro su Bill Evans ("Ritratto d'artista con pianoforte" pubblicato a metà degli anni '90 dalla casa editrice "Stampa Alternativa," ora fuori catalogo), era fatale che gli chiedessi qualcosa di quella sua stagione artistica memorabile. Tra le varie cose che mi disse una mi colpì particolarmente: che, contrariamente a quanto pensavo, il "divorzio" tra i due, un "divorzio" che arrivava dopo otto anni di collaborazione dai risultati strabilianti, non era stato provocato da Evans ma proprio da Motian. Lui mi disse infatti che, insoddisfatto della musica che si suonava in quel gruppo, decise di andar via dopo la registrazione di Trio '64 sbattendo la porta e, a quanto pare, trattando piuttosto male Evans. Un'informazione sorprendente ma, data la fonte certamente preziosa, la inserii nella seconda edizione del libro. Per la prima edizione, del quale gli avevo invece chiesto di scrivere una prefazione, non lo fece direttamente ma mi fece un regalo: mi autorizzò ad utilizzare un passo della sua autobiografia, che purtroppo non ha mai terminato, in cui parlava del suo primo incontro con Bill Evans, a metà degli anni '50, in occasione di un'audizione cui entrambi parteciparono. Un piccolo episodio che si sarebbe rivelato fondamentale alla luce di quanto accadde di lì a poco: l'incisione del suo primo disco con Evans e la successiva nascita dello storico trio con Scott LaFaro.
AAJ: Andiamo un po' più indietro nella tua storia musicale e parliamo di un altro tuo grande incontro: quello con Chet Baker.
EP: Fu un incontro decisivo. Chet fu il vero ispiratore inconsapevole di quel cambiamento, e gliene sono grato. Alla fine degli anni '70 i miei pianisti di riferimento erano prevalentemente quelli bop e hard bop, con l'aggiunta di McCoy Tyner, se ne sente l'influsso in modo evidente in From Always to Now in quartetto del 1978, da poco ripubblicato in CD dalla Alfa Music. Avevo una tecnica evolutissima, tanta energia, fantasia, voglia di dire, di fare, ma diverse cose del mio modo di suonare mi lasciavano insoddisfatto. L'incontro con Chet arrivò nel momento giusto. Accadde nel novembre del 1979. Col mio trio di allora Riccardo Del Fra e Roberto Gatto andammo a Macerata per un concerto con lui, il primo della mia vita. Alla fine della bellissima, emozionante serata, facendomi coraggio, chiesi a Chet se gli andava di fare un disco con me e quel trio. Lui mi disse "ci devo pensare." Dopo una settimana mi chiamò per dirmi, con mia grande gioia, che accettava. Mi misi subito a scrivere dei pezzi su misura per lui e poco dopo registrammo il nostro primo disco insieme.
AAJ: Un altro disco fondamentale per questo cambiamento stilistico fu sicuramente il successivo disco Soft Journey
EP: Precisamente. Un disco importante nella mia vicenda musicale, non solo perché documentava il primo incontro su disco di un mito della storia del jazz con dei giovani musicisti romani, oltre a me nel gruppo figuravano Maurizio Giammarco, Riccardo Del Fra e Roberto Gatto, ma perché fu proprio quel disco a segnare l'inizio della mia trasformazione stilistica. Tutto cominciò durante le prove per la registrazione di Soft Journey. Chet, seduto accanto a me con la sua tromba, suonava poche, bellissime note, piene di feeling e di un'incredibile magia narrativa. E io mi chiedevo ogni giorno: "Come fa?." Cominciai a penetrare nel suono della sua tromba, a farmene avvolgere per cercare di "rubargli" qualcosa. Non le note in sé, ma tutto quello che c'era dietro. Quei giorni di prove e registrazioni furono decisivi e indimenticabili: a pochi metri da me c'era un universo sonoro al cui fascino era impossibile resistere e lì c'era la chiave di quello che cercavo.
AAJ: Hai dovuto perciò lavorare sulla sottrazione?
EP: Sì. Sulla ricerca dell'essenzialità, sul senso delle frasi. O se preferisci sulla melodia, sulla cantabilità. Fu l'inizio di un lungo percorso verso un mondo completamente diverso da quello che avevo esplorato e praticato fino ad allora. Da Soft Journey in poi, nei concerti con Chet degli anni successivi, in quella contiguità fatta di pochissime parole e tanta, intensissima emozione musicale, si gettarono i semi di quanto sarebbe avvenuto dopo alcuni anni, vale a dire l'avvicinamento a Bill Evans e al suo pianismo, la riscoperta della sua dimensione artistica più profonda e una radicale trasformazione del mio modo di suonare.
AAJ: C'è quindi secondo te un legame stretto fra il modo di suonare di Chet Baker e quello di Bill Evans?
EP: Senz'altro. Un'affinità non sempre adeguatamente evidenziata. Chet e Bill Evans avevano entrambi un dono piuttosto raro: saper raccontare, col loro strumento, una storia. Sono stati due artisti che hanno dimostrato chiaramente come nel jazz l'interpretazione può essere più importante o almeno importante quanto l'improvvisazione. Basti pensare alla estrema cura con cui entrambi esponevano i temi di standard ben noti. Le note erano quasi quelle della melodia originale, poche differenze. Eppure, bastavano pochi secondi per accorgersi che quella melodia sembrava esser stata scritta da loro, sembrava che la stessero inventando loro in quel momento, suonandola per la prima volta. Se ne impadronivano facendone la loro storia, esattamente come fanno i grandi attori con un testo teatrale. Loro, invece del testo, usavano una melodia nel cui mood si immergevano totalmente e nota per nota ti costringevano ad ascoltarla, a seguirla, a star lì per sapere come sarebbe andata avanti. Proprio come avviene quando si ascolta una storia detta da qualcuno che la sappia davvero raccontare bene. Spesso i giovani studenti di jazz trascurano questo aspetto del suonare, concentrandosi sull'improvvisazione, sulle scale, sul sapere tutto, i nomi, la teoria ecc. Dimenticano che suonare è un'opportunità unica per raccontare te stesso, non per far vedere al mondo quanto sei bravo. Io credo che l'esempio di Chet Baker e Bill Evans, sotto questo aspetto, dovrebbe essere seguito molto di più. Una forza interpretativa, la loro, che spiega tra l'altro perché entrambi sono stati così amati e perché la loro musica ancora oggi possa facilmente conquistare anche chi non è un ascoltatore abituale del jazz. Ai miei studenti di pianoforte raccomando sempre di ascoltare in generale i trombettisti e in particolare Chet. L'obiettivo è la cantabilità, che sul pianoforte, per la natura dello strumento, è tutt'altro che semplice da ottenere.
AAJ: In fase di registrazione del disco Soft Journey era l'atteggiamento ribelle e autodistruttivo a prevalere su quello malinconico e sensibile di Chet Baker, o viceversa?
EP: Ovviamente sapevo dei "problemi personali" di Chet e lui sapeva che io, come tutti, sapevo. Ma il nostro rapporto era di tale empatia musicale da lasciar completamente fuori l'aspetto "sbagliato" della sua personalità. Ci siamo incontrati sulla musica. Ed è stato un incontro bellissimo fatto di tanto feeling e quasi nessuna parola. Perché le parole non servivano. Del "poeta maledetto" che era in lui, francamente, non mi importava niente. Quello che mi interessava e mi turbava era la sua sterminata musicalità. Ogni volta che suonavamo insieme, mi faceva viaggiare per zone della musica che non avevo mai conosciuto prima. Il resto non mi interessava. Comunque, volendo parlare dei famosi "problemi personali," non è affatto vero, come molti superficialmente ancora pensano, che Chet suonava così perché era un drogato. Era esattamente l'opposto: suonava così nonostante la droga. La musica in Chet era migliaia di volte più profonda e forte di tutta la droga che ha preso. È stata la musica a tenerlo in vita, non la droga. È grazie alla musica che riuscì a superare vicende tristemente note che erano conseguenza delle sue storie di droga. Ed è per questo che bisognerebbe occuparsi molto di più della sua musica che non dei suoi "problemi personali." C'è tanto da imparare là.
AAJ: Diverse tue composizioni sono diventate nel tempo dei veri e propri standard, al punto da essere inseriti nell'imprescindibile Real Book.
EP: Per me la composizione è un'estensione dell'improvvisazione, la sua naturale conseguenza. Improvvisare bene è fondamentale, ma per sviluppare e proporre in maniera molto più forte la tua identità artistica, devi cercare di scrivere la tua musica. Se poi questa comincia ad essere oggetto di attenzione da parte di musicisti, editori, produttori, è evidentemente una grande soddisfazione. Per esempio "Fellini's Waltz" ha cominciato a diventare molto più visibile da quando Lorraine Feather, figlia del grande critico Leonard e bravissima cantante soprattutto di musical, ha sentito il brano e ha deciso di metterci delle parole, molto belle, incidendolo poi in un suo CD dal titolo Tales From the Unusual. Quanto ai "Real book," furono "Don't Forget the Poet" e "Dee Song" i miei primi due brani inseriti nei "New Real Books." Facevano parte entrambi di Deep Down, un disco del 1986 in trio con Marc Johnson e Joey Baron e fu proprio Marc, amico di Chuck Sher, l'editore dei "New Real Books," a dargli una copia di quel CD. Sher mi contattò e i brani furono inseriti nell'edizione del 1991 dei suoi libri. Un grande onore per me.
AAJ: Come nasce invece la storia di "Night Bird" uno dei brani più celebri del tuo repertorio compositivo anche questo diventato nel tempo un classico della musica jazz e presente nel disco From Always to Now che hai citato prima?
EP: Scrissi "Night Bird" tanto tempo fa, nel 1977 credo. Era il mio periodo Bop-Hard bop e il pezzo rientrava in quello stile. È un blues in minore leggermente modificato rispetto all'armonia usuale di questa forma jazzistica. Lo incisi la prima volta nel '78, in quartetto in From Always to Now, che abbiamo citato prima. Quando poi alla fine del 1979 registrai Soft Journey, il mio primo disco con Chet Baker, pensai di includerlo. Chet se ne innamorò immediatamente, lo inserì stabilmente nel suo repertorio e cominciò a suonarlo e registrarlo in tutto il mondo, insegnandolo ad altri musicisti di ogni nazionalità. Divenne in un certo senso l'"ambasciatore" di quel pezzo... e anche del suo autore.
AAJ: Torniamo a From Always to Now del 1978. Quali sono le circostanze che portarono alla registrazione di questo disco?
EP: From Always to Now fu il quarto disco a mio nome. Il primo, registrato tre anni prima, era in trio, i due successivi in piano solo. Pensai fosse il momento di provare a cimentarmi col quartetto. Eravamo tutti molto giovani. Quando lo incidemmo io avevo poco più di ventotto anni, Maurizio Giammarco ventisei, Roberto Gatto, che in quel disco fece il suo debutto discografico assoluto, addirittura venti. Il più "anziano" era Bruno Tommaso, trentadue anni. Era un periodo di grande fermento e sperimentazione per tutto il jazz romano. La scena era molto più animata rispetto alla fine del decennio precedente, quando avevo mosso i miei primissimi passi in pubblico. Tra l'inizio e la fine egli anni '70 vennero fuori parecchi nuovi musicisti di valore.
AAJ: C'era un nascente movimento di giovani jazzisti: Enzo Pietropaoli, Maurizio Giammarco, Roberto Gatto...
EP: Sì, cominciavano ad apparire finalmente diversi musicisti di talento, anche in strumenti prima d'allora decisamente carenti, contrabbasso e batteria, per esempio. Il più rappresentativo tra questi era comunque Massimo Urbani che, pur giovanissimo—nel '78 aveva solo 21 anni—paradossalmente era già un "anziano" rispetto a quella nouvelle vague di musicisti. S'era infatti già messo in evidenza anche a livello nazionale qualche anno prima, nel 1972, quando a Giorgio Gaslini era stata affidata la cattedra di jazz al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Quella cattedra divenne un importante polo di attrazione per molti giovani musicisti desiderosi di suonare insieme, di cercare, di sperimentare. Tra questi, appunto, Massimo.
AAJ: I musicisti giovani ti vedevano già allora come un jazzista affermato, un modello di riferimento.
EP: Sembra che gran parte di questo "carisma" e, mi dicono anche della soggezione che sembra incutessi, fosse dovuto al fatto che ero diplomato in pianoforte. Prima d'allora non era mai apparso all'orizzonte—non solo a Roma, ma nemmeno in Italia—un musicista jazz con un background classico "serio." Ero decisamente un'anomalìa, un caso. Anche la mia figura fisica, il mio modo di fare, gli occhiali, l'abbigliamento, sembra stridessero rumorosamente con lo stereotipo del musicista di jazz. Sostanzialmente ero un alieno, uno che sembrava venire da un altro mondo. Questo background "serio" o "serioso" contrastava inoltre completamente con lo stile dominante a Roma in quegli anni, che non era il bop, ma il free. Fui comunque il primo dei giovani musicisti romani a confrontarsi con i grandi solisti americani di passaggio a Roma. Me ne diede l'opportunità Pepito Pignatelli, mio grande sostenitore e geniale inventore del Music Inn, club storico romano in cui, a partire dal 1974, mi trovai a suonare a fianco di leggende come Johnny Griffin, Kenny Clarke, Art Farmer, Sal Nistico. Agli occhi dei musicisti di qualche anno più giovani come appunto Gatto, Pietropaoli ecc. che venivano a sentirmi sembrai probabilmente una sorta di coraggioso "esploratore di nuove terre," uno che apriva una nuova strada, che mostrava una possibilità. In questo senso, sì, mi consideravano "affermato." Ai loro occhi avevo insomma già una mia piccola storia.
AAJ: Com'era la situazione economica dei musicisti di quel periodo? E pensi che oggi sia cambiata sotto questo aspetto?
EP: Allora era impensabile vivere di jazz. Oggi lo è, non è semplice, ma lo è. Non c'era un vero e proprio "mercato del jazz," soprattutto in Italia. Eravamo tagliati fuori dall'Europa. I festival erano agli albori e all'interno di questi la situazione dei musicisti italiani era fortemente penalizzata. Da questo punto di vista non mi sembra che le cose siano molto cambiate. I musicisti di jazz bravi di quel tempo per vivere decorosamente dovevano avere un'attività legata alla musica di intrattenimento, suonare nei "night club." Come del resto quelli della generazione precedente. Mio padre, che verso la fine degli anni '40 era il miglior chitarrista blues di Roma, suonava nei "night" con propri complessi perché altrimenti non ce l'avrebbe potuta fare. L'altra possibilità era far parte di orchestre come quelle RAI, penso a musicisti come Oscar Valdambrini Gianni Basso e Dino Piana. Ma vivere solo di jazz era praticamente impossibile.
AAJ: Nelle note di copertina di From Always to Now tu scrivi " Simili ai granelli di sabbia della clessidra... inesorabili "now" si sono succeduti." Quali sono i "now" in questo momento di Enrico Pieranunzi?
EP: Sono da poco usciti due miei nuovi CD: uno in solo, Frame, per la Camjazz, che era in attesa di pubblicazione dal 2012; e uno in trio per la Challenge, Common View, registrato in Olanda a fianco di Jasper Somsen e Jorge Rossy. Frame è un CD completamente diverso da ogni altro piano solo che ho registrato in passato. I brani sono ispirati e idealmente collegati allo stile di grandi pittori del XX secolo come Pollock, Rothko, Hopper, Klee ecc. Molti brani sono decisamente sperimentali e percorrono un "now" molto diverso dall'usuale. Stessa cosa per il CD in trio, che propone brani originali di tutti e tre, molto variegati come atmosfera. Insomma sono sempre alla ricerca di "now" nuovi, emozionanti, sia come performer che come compositore. Per me scrivere e suonare hanno infatti la stessa, importante valenza. Quando inventi un pezzo che sai esser vero, lo puoi sentir respirare e vivere tra le tue dita. Ecco, quel "now" è un momento bellissimo, irripetibile e misterioso e quando arriva è come un dono. Spero che "now" di questo tipo non smettano mai di arrivare.
AAJ: Sono pochi i musicisti jazz che riescono ad avere un linguaggio con il proprio strumento che si differenzia dagli altri, una voce che richiami un suono unico. Tu sei uno di questi. Nel tempo hai costruito un lessico pianistico unico nel panorama internazionale: quali sono gli elementi che ti hanno portato a questo risultato?
EP: Intanto ti ringrazio perché, nel jazz, riuscire ad avere un suono personale è un grande risultato. Però non ti nascondo che quando, come hai fatto tu, mi viene detta questa cosa, provo un mix di sorpresa e disagio. Semplicemente perché l'ultimo a poterti rispondere su come questo suono personale sia stato ottenuto sono proprio io. Il suono per un musicista è una rappresentazione e una prosecuzione di sé. Anche del sé a te sconosciuto. Per cui da fuori magari si possono cogliere molte più cose di quelle che il musicista, consapevolmente o inconsapevolmente mette nella sua musica. Un tuo brano può dare a chi ascolta un'impressione totalmente diversa da quello che il musicista sta provando. Inoltre, la formazione del suono è indissolubilmente intrecciata con il tuo percorso esistenziale, col tuo mondo interiore, non lo crei a tavolino, è un risultato in gran parte involontario. Però, per abbozzare una risposta, potrei azzardare che nel tempo le mie "due vite," quella di pianista classico e quella di pianista di jazz, si sono fuse in maniera particolare dando vita ad un linguaggio personale. Ma all'interno di questa "cornice" sono accadute e accadono tante di quelle cose che distinguere i vari ingredienti mi sembra un'operazione piuttosto complicata.
AAJ: È cambiata più la società o il movimento jazzistico nel corso degli anni?
EP: Direi che a partire dalla diffusione planetaria dei social è cambiata più la società. Come conseguenza è cambiato radicalmente il pubblico, i suoi gusti, i suoi modi e tempi di fruizione. E ovviamente i social hanno cambiato anche i musicisti, il loro modo di concepire, eseguire, organizzare la musica. Infine è cambiato il mondo della produzione musicale. Una bella rivoluzione insomma, che stiamo tutti attraversando. Un grande, ulteriore cambiamento riguarda poi il rapporto del pubblico e dei musicisti col passato di questa musica, o forse col passato di ogni musica, o forse col passato tout court. Se penso alle diatribe feroci che scoppiarono all'apparire del—Miles Davis elettrico (fine anni '60) e che divisero come in una vera e propria guerra "tradizionalisti" e "modernisti," gli uni contro quelle innovazioni di Davis che ritenevano vere e proprie bestemmie musicali, gli altri ad esse favorevoli. Altri mondi, che non torneranno mai più. Io però continuo ad avere fiducia nella qualità forse più caratteristica del jazz: la duttilità, la flessibilità, la plasticità, che i cambiamenti degli ultimi anni hanno forse stimolato ulteriormente. Il jazz ne ha sempre dato prova e anche in quest'epoca lo può fare. Certo, dobbiamo abituarci a vivere senza "punti fermi." La "tradizione," per esempio, in questi tempi di eterno presente sembra un termine sempre più vago. Quanto al futuro... Non so proprio dirti. Chi vivrà, vedrà.
AAJ: Come vedi la distribuzione e la fruizione della cultura e in particolare della musica nel nostro Paese?
EP: Dipende se vogliamo essere pessimisti o ottimisti. Nel primo caso si potrebbe in maniera forse clamorosa ipotizzare che molta (bella) musica sparirà. O sparirà addirittura la musica?...mamma mia che scenario... No, meglio andare nella direzione opposta. Ecco, per sorridere ed essere positivi basta pensare che ci sono tanti ragazzi bravi su cui contare. Non molto tempo fa per esempio ho registrato un disco con un gruppo di giovani musicisti, un progetto che ho chiamato "Enrico Pieranunzi Youth Project" e che sarà prodotto dalla Alfa Music. Una scommessa per il futuro data l'età media, neanche 25 anni, dei componenti del gruppo. Leader escluso, naturalmente...
< Previous
I'm Gonna Go Fishin' on a Sunday Afte...
Next >
Vernal Equinox
Comments
About Enrico Pieranunzi
Instrument: Piano
Related Articles | Concerts | Albums | Photos | Similar ToTags
Interviews
Enrico Pieranunzi
Paolo Marra
Chet Baker
Bill Evans
Paul Motian
Paolo Damiani
Keith Jarrett
Charlie Haden
Dewey Redman
Bill Frisell
joe lovano
Marc Johnson
Kenny Wheeler
Chris Potter
Kurt Rosenwinkel
Scott LaFaro
Riccardo Del Fra
Roberto Gatto
Maurizio Giammarco
Joey Baron
Bruno Tommaso
Enzo Pietropaoli
Massimo Urbani
Giorgio Gaslini
Johnny Griffin
Kenny Clarke
Art Farmer
Sal Nistico
Oscar Valdambrini
Gianni Basso
Dino Piana
Jasper Somsen
Jorge Rossy
For the Love of Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who create it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who create it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.


























